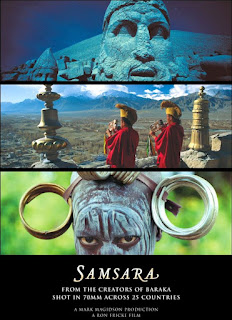Delle 5 commedie messicane del
dopoguerra inserite in questo gruppo, 4 furono dirette dall'acclamato regista spagnolo in
esilio oltreoceano e fanno parte della sua produzione meno conosciuta; pur non
essendo capolavori, ebbero successo e gli permisero di girare film
indimenticabili come Los olvidados, El, El
angel exterminador, Viridiana ...
In effetti molti degli oltre 30 film
di Buñuel hanno una parte di commedia, a volte solo in alcune scene o
per dei personaggi grotteschi come i mendicanti che partecipano al banchetto di
Viridiana o ancor più chiaramente negli ultimi suoi film seppur
con vena surrealista. Anche le sceneggiature di quelli
apparentemente più drammatici contengono spesso incisivi spaccati sociali seppur
presentati con sarcasmo, sia degli ambienti ricchi (Ensayo de un crimen,
El, ...) sia fra i meno abbienti ed emarginati (Los olvidados);
altre volte li mette a confronto come in Journal de una femme de chambre
o El gran calavera. Quest’ultimo fu il suo primo vero film
considerato che le due pietre miliari del surrealismo (di una ventina di anni
prima) erano di durata ridotta e dopo una lunghissima forzata pausa, aveva
ripreso nel 1947 con Gran Casino, più che altro un musical con la
star dell'epoca Jorge Negrete.
Si devono altresì sottolineare i grandi meriti di Luis Alcoriza (anche lui spagnolo in esilio) non per il piccolo ruolo in El gran calavera, bensì per essere suo sceneggiatore quasi imprescindibile durante tutto il periodo messicano. Infatti, delle suddette 4 commedie solo Subida al cielo non è opera sua e fu autore anche di Los olvidados (1950), El bruto (1953), El (1953), El río y la muerte (1954), giusto per restare in quel quinquennio, ma voglio ricordare che nel 1962, insieme con lo stesso Buñuel che poi stese la sceneggiatura definitiva, scrisse anche il soggetto di uno dei suoi migliori film in assoluto: El ángel exterminador (IMDb 8,1 e 93% su RT, Miglior film del 1963 per Cahiers du Cinéma, Premio FIPRESCI e Nomination Palma d'oro a Cannes).
Ho voluto iniziare questa breve
rivista delle sue commedie più classiche del periodo messicano con El
gran calavera non solo per procedere in ordine cronologico, ma anche
perché fu quello che mi fece scoprire quest’altra faccia di Buñuel. Mi
ci imbattei al Museo de las Culturas a Ciudad de Mexico nel 1983, quando
conoscevo solo i due lavori surrealisti e quelli girati in Europa (soprattutto
in Francia) dove la maggior parte dei film diretti oltreoceano (in particolare
quelli destinati al grande pubblico) erano praticamente sconosciuti. Nel
quinquennio nel quale furono prodotte queste 4 commedie Buñuel fu
particolarmente attivo, dirigendo una dozzina di film (oltre un terzo della sua
filmografia di appena una trentina di titoli) alternando commedie di cassetta,
film più impegnati e anche alcuni dei suoi più famosi film drammatici nei
quali, comunque non è mai del tutto assente la vena grottesca.
El Gran calavera (Luis Buñuel, Mex, 1949)
Venendo ai film di questo gruppo, e
procedendo in ordine cronologico, il primo è basato su una commedia di successo,
adattata da Luis Alcoriza e sua moglie Janet. Il protagonista,
ricchissimo industriale alcolizzato, è attorniato da parenti e dipendenti che
sfruttano la sua bontà d’animo e generosità, vivendo da veri parassiti. Una
originale terapia d’urto ideata da un suo fratello (onesto medico) porterà ad
una serie di cambiamenti radicali e colpi di scena fino all’ultima scena,
mettendo in risalto differenze fra gli stili di vita dei possidenti e dei
lavoratori. Nel 2013 Gary Alazraki ne ha diretto un remake (Nosotros
los Nobles) adattato ai tempi moderni, campione d’incassi in Messico.
La hija del engaño (Don Quintín el amargao) (Luis Buñuel, Mex, 1951)
Si tratta di una commedia drammatica
che vede di nuovo l’ottimo e versatile Fernando Soler nei panni del
protagonista, un uomo divenuto scontroso e a volte violento dopo aver scoperto
il tradimento della moglie, cacciata di casa all’istante. Non posso aggiungere
altro per evitare spoiler, ma sappiate che i due titoli alternativi forniscono
chiari indizi. In effetti il secondo è il titolo dell’originale commedia
spagnola della quale già erano state realizzate versioni cinematografiche nel
1925 e nel 1935; della seconda Buñuel fu produttore e collaborò (uncredited)
sia alla regia che all’adattamento, pertanto alcuni considerano la versione del
’51 un remake di un proprio film. Circolò in penisola iberica dal 1974 e poi fu
presentato a Berlino nel 2009.
Subida al cielo (Luis Buñuel, Mex, 1952)
Altro film pieno di personaggi e
situazioni più o meno grottesche, fra comedia negra, dramma, realismo e
road movie. Tutta la consistente parte centrale descrive un relativamente lungo
viaggio in bus con un giovane sposo insistentemente tentato da una bellezza
locale, un aspirante deputato, un rappresentante di galline, capre, una bara
(piena) con seguito, bambini pestiferi; aggiungete festa della madre dell’autista
che invitati tutti i passeggeri, ai quali si aggiungono turisti americani,
guadi di fiume, pericolose strade sul ciglio di un precipizio, e altro ancora
che lasciano inizio e fine come causa del viaggio, fondamentale per il
protagonista, ma in effetti poco importante per il film nel suo complesso.
La ilusión viaja en tranvía (Luis Buñuel, Mex, 1954)
Qui non c’è un bus, bensì un tram di
Ciudad de Mexico che deve essere demolito, ma due dipendenti dell’azienda (uno pretendente
della sorella dell’altro) decidono di fargli fare un’ultima corsa. Come nel
film precedente, in questo viaggio, seppur urbano, succederà pressoché di tutto
e i due si confronteranno con tante situazioni certamente impreviste e soprattutto
con un anziano tramviere in pensione, claudicante e irriducibile, che li
smaschera e li persegue.
Allà en el rancho grande (Fernando de Fuentes, Mex, 1949)
Non proprio un musical, ma certamente
i pezzi cantati da Jorge Negrete (il protagonista) e da altri occupano
parte importante del film. Si tratta di un remake dell’omonimo film diretto
dallo stesso regista nel 1936, ma né l’uno né l’altro sono di qualità
paragonabile ai film della Trilogia de la Revolucion: El
prisionero trece (1933), El compadre Mendoza (1934) e Vámonos
con Pancho Villa (1936). Film certamente evitabile pur avendo avuto un
certo successo durante la Epoca de Oro del Cine Mexicano.