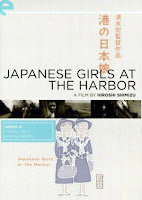Dopo tante quasi-monografie o gruppi dedicati in prevalenza ad un regista, paese o genere, ecco una cinquina estremamente varia: 5 paesi differenti, generi diversi, fra gli anni ’30 e il 2007. Il film Berlanga è nettamente il migliore, sotto ogni punto di vista, Polanski conferma la sua abilità nei film con pochissimi personaggi, il crime di Haggis è sufficiente, Shimizu ha prodotto senz’altro di meglio, il portoghese Canijo molto deludente.
Los
jueves, milagro (Luis García Berlanga, Spa,
1957)
Deliziosa comedia negra del realismo spagnolo prodotta con molto poco, utilizzando come set il piccolo paesino Alhama de Aragón (Fuentecilla nel film), noto per le sue acque termali che sono parte fondamentale della storia, insieme con San Dimas (San Disma in italiano, il ladrone buono crocifisso al lato di Gesù). Oggi conta poco più di 1.000 abitanti e non penso che all’epoca fossero molti di più e tanti interpretarono i loro personaggi reali, specialmente nelle scene in chiesa e quelle delle processioni. Le spese per il cast “di grido” fu fra le maggiori di questa produzione italo-spagnola evidenziata dalla presenza (al fianco degli onnipresenti spagnoli Isbert e López Vázquez) di Paolo Stoppa e Richard Basehart (che all'epoca lavorava in Italia essendo sposato con Valentina Cortese) … di conseguenza esiste la versione italiana (bravo chi la trova) con titolo Arrivederci Dimas.
Un’altra perla frutto della creatività e genialità di Berlanga, un maestro in questo genere, che riusciva a fare critica sociale mascherandola da commedia in modo da evitare la censura franchista (p.e. Bienvenido Mister Marshall e Placido). Visto per la prima volta meno di un anno fa, ho voluto guardarlo di nuovo per aver trovato copia migliore e sono stato molto contento di averlo fatto. I volti dei veri abitanti del paesino, i loro atteggiamenti e la descrizione dell'ambiente sono imperdibili ... consigliatissimo.
Death
and the Maiden (Roman Polanski, UK/Fra, 1994)
Film con tre soli personaggi, che si svolge nel corso di una notte, in una casa isolata nei pressi di una scogliera, in un paese da poco uscito da un periodo di dittatura. Tre persone colte e formali, una coppia ed uno sconosciuto che ha aiutato l’uomo che era in difficoltà con la sua auto. Improvvisamente qualcosa cambia e la tensione sale rapidamente alle stelle, il rapporto fra i tre diventa violento, fra minacce, accuse e bugie. Purtroppo si perde nel finale e nel brevissimo seguito, con un salto temporale. Le star sono Sigourney Weaver e Ben Kingsley (l’uomo misterioso), ma il semisconosciuto Stuart Wilson non sfigura. Di chiara derivazione teatrale (dramma dell’argentina Ariel Dorfman, e si comprende il perché del tema), riesce comunque a mantenere sempre alta l’attenzione. Sembra che questo tipo di situazioni siano amate da Polanski visto che il regista polacco, fra suoi soli 24 film in oltre 50 anni, conta (a mia memoria) conta altri due film concettualmente simili: Il coltello nell’acqua (1962, suo esordio, Nomination Osca e FIPRESCI a Venezia) e il molto più recente Carnage (2011).
In
the Valley of Elah (Paul Haggis, USA, 2007)
Crime in ambito
quasi militare, incentrato sulla misteriosa scomparsa di un soldato da poco rientrato
dall’Iraq e i titoli di testa ci fanno sapere che il soggetto è ispirato a
fatti reali. Tommy Lee Jones (Nomination Oscar per questa interpretazione)
è il padre alla ricerca della verità, Charlize Theron la detective (derisa
da superiori e colleghi) che si fa carico dell’indagine e degli inevitabili
scontri con le reticenze e ostacoli opposti dai militari. Molti personaggi non
convincono del tutto e lo sviluppo è molto più lento del necessario, il film
non riesce a coinvolgere più di tanto, anche se è ben realizzato. Se piace il genere
può piacere, ma gli altri lo troverebbero noioso ... a voi la scelta.
Japanese
Girls at the Harbor (Hiroshi Shimizu, Jap, 1933)
Shimizu fu uno di quei registi che fece
storia nel cinema giapponese dirigendo ben 148 film, cominciando nel 1924 (a
soli 21 anni) e fu uno di quelli che continuò a girare muti, come questo, ben
oltre gli anni dell’avvento del sonoro. I suoi migliori furono senz’altro
quelli realistici, con tanti bambini e giovani come protagonisti. Amico e
collega di Ozu, fu anche molto apprezzato da Kenji Mizoguchi, ma
questo, pur realizzato con il suo solito stile chiaro e descrittivo, non è riuscito
a coinvolgermi; a chi non lo conosce consiglierei di cominciare con altri suoi
film.
Sangue do meu sangue (João Canijo, Por,
1994)
Senza dubbio il
più deludente di questa cinquina. Molto quotato in patria, dove ha ottenuto
molti premi (ma l’attuale produzione lusitana non è di gran livello), si
risolve nella descrizione di una famiglia mal assortita di ceto medio-basso
nella quale sembra che si faccia a gara a chi si comporta in modo più irrazionale.
Canijo (regista e sceneggiatore) ha voluto concentrare in una mezza
dozzina di personaggi troppi problemi sociali e ciò, oltre a sembrarmi
eccessivo per chiunque, non è assolutamente nelle sue capacità; oltretutto,
oltre la brava Rita Blanco, il resto degli interpreti non è convincente.
Risulta abbastanza deprimente e anche irritante per l’insulsaggine dei
personaggi. Visione che si può evitare.