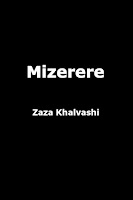Continuando il viaggio in Francia ho guardato altri due
lungometraggi (sonori) di Epstein e un programma di 4 suoi corti,
seguiti da tre film di Marcel L'Herbier (altro notevole regista dell’avant-garde
degli anni ’20); ho concluso il tema francese con un film di Genina che
vede la diva di allora Louise Brooks quale protagonista. Infine, ho
completato la decina con 3 film russi di due registi che, con Eisenstein
e Vertov, furono i pilastri del cinema sovietico non solo come autori ma
anche come teorici, le cui idee in merito a riprese e montaggio sono state alla
base della cinematografia moderna.
L'or des mers (Jean
Epstein, Fra, 1932)
L'homme à l'Hispano (Jean
Epstein, Fra, 1933)
Le Tempestaire (Jean
Epstein, Fra, 1947) e altri 3 corti (1927-30-31)
Il primo è quasi una parabola, ambientato in un piccolo e
desolato villaggio di pescatori della Bretagna, con molti temi simili a quelli
dei corti: onde, vento, povertà, fari, pesca, soccorso in mare, …; a volte
incluso nei documentari pur avendo una ben precisa trama, fu girato muto ma
successivamente sonorizzato.
L'homme à l'Hispano si
svolge invece in tutt’altro ambiente, quello della ricca élite francese, fra
Parigi e (soprattutto) Biarritz, ed è di genere indefinibile … fra dramma,
commedia romantica e affari, adattato da un romanzo di Pierre Frondaie
dallo stesso Epstein. Fu il primo vero sonoro del regista, piacevole e
ben interpretato anche ben diverso dai muti di avant-garde.
L'inhumaine (Marcel
L'Herbier, Fra, 1924)
Feu Mathias Pascal
(Marcel L'Herbier, Fra, 1926)
L' Αrgent
(Marcel L'Herbier, Fra, 1928)
L'Herbier fu il quarto cineasta di spicco degli anni ’20
francesi, insieme con Gance, Epstein e Dulac. Quelli che
ho guardato sono i più famosi, penso giustificatamente. Sono tutti e tre molto
ben messi in scena anche se hanno molto poco in comune. L'inhumaine è
quello che cinematograficamente ho preferito per tecnica e scenografie fra espressionismo
tedesco e cubismo, ma la sceneggiatura è troppo fantasiosa e pretestuosa. Il
secondo è ovviamente basato sull’omonimo romanzo di Pirandello e, come spesso
accade per gli adattamenti cinematografici, non è fedelissimo all’opera
originale.
L' Αrgent è il più “violento” dei tre, con personaggi
molto aggressivi, tutti mossi quasi esclusivamente dall’adorazione per il
denaro. Migliore dei tre per rating IMDb, mi sono piaciute le interpretazioni e
anche il montaggio.
Prix de beauté
(Augusto Genina, Fra, 1930)
Primo film in Francia dell’italiano Genina, con la
diva/antidiva americana Louise Brooks (pessimo il suo rapporto con Hollywood),
con sceneggiatura di René Clair e G. W. Pabst che l’aveva diretta
negli altri suoi due film europei: Diario di una donna perduta e Il
vaso di Pandora (aka Lulù), entrambi del 1929. Inizia come una commedia
romantica, si trasforma in dramma e termina come crime. Miss Europa
(titolo italiano) si lascia guardare ma da tutti questi grandi nomi ci si
sarebbe aspettato di più.
Secondo la legge (Lev
Kuleshov, URSS, 1926)
La fine di San Pietroburgo (Vsevolod
Pudovkin, URSS, 1927)
Tempeste sull'Asia (Vsevolod
Pudovkin, URSS, 1928)
Se Eisenstein è indubbiamente il più conosciuto
regista sovietico degli anni ’20 (La corazzata Potëmkin, 1925 e Ottobre,
1928), a livello di tecnica, innovazione e teoria cinematografica Kuleshov
e Pudovkin non sono certamente da meno. Stranamente, Secondo la
legge è un adattamento del racconto The Unexpected (1906,
di Jack London), è ambientato sulle rive dello Yukon in Alaska e conta
su soli 5 personaggi (cercatori d’oro) che ben presto diventano tre.
Svolgendosi per lo più nella rustica baracca e nelle immediate vicinanze ha una
struttura quasi teatrale, piena di tensioni. Il finale è da vera short story,
inaspettato, come anticipato anche dal titolo.
Al contrario, i due film di Pudovkin sono ciò che
chiunque si sarebbe aspettato … film quasi di sola propaganda, il primo più che
dichiaratamente visto che fu prodotto in occasione del decennale della Rivoluzione.
Le trame sono quindi scontate e, in parte, esagerate, ma la tecnica,
specialmente quella dei rapidi montaggi è senz’altro di altissimo livello.
Visualizzazione post con etichetta Epstein. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Epstein. Mostra tutti i post
martedì 7 aprile 2020
Micro-recensioni 101-110: ancora francesi d'epoca e teorici del cinema russi
Etichette:
cinema,
Dulac,
Eisenstein,
Epstein,
film,
Genina,
Kuleshov,
L'Herbier,
Louise Brooks,
muto,
Pudovkin,
Vertov
mercoledì 1 aprile 2020
Micro-recensioni 91-100 del 2020: l'avanguardia francese degli anni '20, fra surrealismo e innovazione
Decina quasi monotematica, con i film muti di due soli
registi dell’avant-garde francese degli anni ’20, Germaine Dulac e Jean Epstein, veri innovatori soprattutto
nel campo del montaggio e delle riprese, con tanti primissimi piani dei
protagonisti e un ottimo uso
delle doppie esposizioni che rivelano i loro pensieri, sogni e ricordi. Queste furono
peculiarità dell’impressionismo (cinematografico) francese che centra gran
parte dell’attenzione sui protagonisti ottenendo una narrazione chiarissima, che
non avrebbe neanche bisogno dei sottotitoli (comunque molto pochi).
La souriante Madame Beudet (1923, 43’)
La coquille et le clergyman (1928, 41’)
Comincio con questi due film (restaurati e ricostruiti, con alcuni minuti in più delle versioni che circolavano in precedenza) di Germaine Dulac, seconda regista nella storia del cinema francese, critica teatrale e cinematografica, impegnata nel movimento delle suffragette, teorica del cinema. Il primo è un classico esempio dell’impressionismo francese e oltretutto uno dei primi film etichettati come femmisti, mentre il secondo è certamente surrealista (da molti considerato il primo di tale genere) e precede di oltre un anno la pietra miliare del cinema Un chien andalou, opera di Buñuel e Dalì. Certamente non è paragonabile a questo né al loro successivo L’age d’or (1930), ma gli si deve oggettivamente riconoscere l’originalità della messa in scena, le varie interessanti scenografie che richiamano l’espressionismo tedesco, l’associazione di sensualità e libidine con il prete in abito talare, gli artifici con la pellicola (antesignani degli effetti speciali).
Ho poi proseguito con una serie di medio- e lungometraggi di Jean Epstein, teorico e regista emblematico dell’avant-garde francese, rinviando a data da destinarsi i suoi vari short e documentari (altrettanto ben quotati) disponibili in rete. Questi sono i titoli (anno, durata) degli 8 film guardati, che trattano ambienti ed epoche molto diversi ma in sostanza c’è sempre una parte melodrammatica predominante.
L'auberge rouge (1923, 72’) (poster nella fila sotto)
Dramma ambientato a cavallo dell’800, con due episodi nettamente distinti, con un protagonista comune. Nel corso di una cena in una ricca residenza, uno dei commensali narra (così come gli fu riportato) un fatto di sangue avvenuto 20 anni prima in una locanda di campagna nel corso di un nubifragio. Le scene si alternano e la tensione viene ben mantenuta nel corso dell’intero film.
Coeur fidèle (1923, 87’)
Ambientato nei bassifondi, quasi realistico, ben proposto e interpretato. Storia d’amore interrotta dalla prepotenza di un piccolo criminale malvagio, violento e alcolizzato. Uno dei migliori di questo gruppo.
La belle Nivernaise (1924, 69’)
Vita su una peniche lungo i canali del nord della Francia; il titolo è il nome della chiatta e ciò non può non far pensare al famoso L’Atalante (1934) di Jean Vigo. Pur essendo questo solo il suo terzo film, Epstein si autocita mostrando un poster del suo primo lungometraggio L’auberge rouge (1923) sulla parete del cinema dove vanno i due giovani protagonisti.
Le lion des mogols (1925, 102’)
Anche in questo quasi kolossal (scene di massa e ricchi costumi per rappresentare una reggia del tiranno di un paese esotico non meglio identificato) c’è un riferimento cinematografico e ben più importante. Due ambientazioni ben distinte con l’altra sui set e teatri francesi. Il protagonista è interpretato da Ivan Mosjoukine (qui anche cosceneggiatore), famosissimo in patria fino al momento della rivoluzione; condannato a morte, riuscì a sfuggire all’Armata Rossa e ebbe un discreto successo anche in Europa, ma solo fino alla rivoluzione del sonoro.
Le double amour (1925, 103’)
Interessante melodramma psicologico condizionato dal gioco d’azzardo compulsivo con corsi e ricorsi a distanza di 20 anni.
Six et demi, onze (1927, 84’)
Sarebbe apparso molto migliore se si fosse evitato il pesantissimo, eccessivo e ingiustificato trucco dei fratelli (medici) protagonisti … solo per loro. Faccia bianca, contorno degli occhi e palpebre scurissime, labbra molto marcate, praticamente clown bianchi in questo ennesimo melodramma nel quale tutti gli altri appaiono “normali”.
La glace à trois faces (1927, 45’)
Mediometraggio quasi a episodi (punti di vista, ricordi e speranze di tre donne rispetto ad uno stesso (fatuo) ricco giovane. Ciò che dà valore al film, che per questo è apprezzato, è la tecnica; sceneggiatura debole, riduzione (forse eccessiva vista la durata del film) un romanzo di Paul Morand.
La chute de la maison Usher (1928, 63’)
Probabilmente il più famoso dei film di Epstein, basato sul famoso omonimo racconto di Edgar Allan Poe, adattato da Luis Buñuel che fu anche suo assistente regista come lo era già stato per Mauprat (1925). In questo terror classico si può facilmente ipotizzare la mano di Buñuel per alcuni dettagli non strettamente pertinenti alla trama. La seconda parte del film è un vero esercizio di montaggio e riprese. Parafrasando il titolo di un commento (che condivido): guardatelo sotto ogni aspetto tranne che per la trama e lo troverete ottimo.
In conclusione, questa incursione fra i 13 muti di Epstein evidenzia la sua continua ricerca tecnica ed espressiva, nei vari generi affrontati seppur tutti hanno in comune una parte melodrammatica. Grande importanza ai primissimi piani dei volti, ai dettagli e alla recitazione con le mani. Come punti deboli, vedo l’indugiare troppo a lungo su singole scene (anche quando è perfettamente chiaro il significato) e la scelta (ma solo nei primi film) di far muovere estremamente lentamente i protagonisti, quasi come automi, assolutamente in modo irreale e poco plausibile, inutilmente teatrale.
La souriante Madame Beudet (1923, 43’)
La coquille et le clergyman (1928, 41’)
Comincio con questi due film (restaurati e ricostruiti, con alcuni minuti in più delle versioni che circolavano in precedenza) di Germaine Dulac, seconda regista nella storia del cinema francese, critica teatrale e cinematografica, impegnata nel movimento delle suffragette, teorica del cinema. Il primo è un classico esempio dell’impressionismo francese e oltretutto uno dei primi film etichettati come femmisti, mentre il secondo è certamente surrealista (da molti considerato il primo di tale genere) e precede di oltre un anno la pietra miliare del cinema Un chien andalou, opera di Buñuel e Dalì. Certamente non è paragonabile a questo né al loro successivo L’age d’or (1930), ma gli si deve oggettivamente riconoscere l’originalità della messa in scena, le varie interessanti scenografie che richiamano l’espressionismo tedesco, l’associazione di sensualità e libidine con il prete in abito talare, gli artifici con la pellicola (antesignani degli effetti speciali).
Ho poi proseguito con una serie di medio- e lungometraggi di Jean Epstein, teorico e regista emblematico dell’avant-garde francese, rinviando a data da destinarsi i suoi vari short e documentari (altrettanto ben quotati) disponibili in rete. Questi sono i titoli (anno, durata) degli 8 film guardati, che trattano ambienti ed epoche molto diversi ma in sostanza c’è sempre una parte melodrammatica predominante.
L'auberge rouge (1923, 72’) (poster nella fila sotto)
Dramma ambientato a cavallo dell’800, con due episodi nettamente distinti, con un protagonista comune. Nel corso di una cena in una ricca residenza, uno dei commensali narra (così come gli fu riportato) un fatto di sangue avvenuto 20 anni prima in una locanda di campagna nel corso di un nubifragio. Le scene si alternano e la tensione viene ben mantenuta nel corso dell’intero film.
Coeur fidèle (1923, 87’)
Ambientato nei bassifondi, quasi realistico, ben proposto e interpretato. Storia d’amore interrotta dalla prepotenza di un piccolo criminale malvagio, violento e alcolizzato. Uno dei migliori di questo gruppo.
La belle Nivernaise (1924, 69’)
Vita su una peniche lungo i canali del nord della Francia; il titolo è il nome della chiatta e ciò non può non far pensare al famoso L’Atalante (1934) di Jean Vigo. Pur essendo questo solo il suo terzo film, Epstein si autocita mostrando un poster del suo primo lungometraggio L’auberge rouge (1923) sulla parete del cinema dove vanno i due giovani protagonisti.
Le lion des mogols (1925, 102’)
Anche in questo quasi kolossal (scene di massa e ricchi costumi per rappresentare una reggia del tiranno di un paese esotico non meglio identificato) c’è un riferimento cinematografico e ben più importante. Due ambientazioni ben distinte con l’altra sui set e teatri francesi. Il protagonista è interpretato da Ivan Mosjoukine (qui anche cosceneggiatore), famosissimo in patria fino al momento della rivoluzione; condannato a morte, riuscì a sfuggire all’Armata Rossa e ebbe un discreto successo anche in Europa, ma solo fino alla rivoluzione del sonoro.
Le double amour (1925, 103’)
Interessante melodramma psicologico condizionato dal gioco d’azzardo compulsivo con corsi e ricorsi a distanza di 20 anni.
Six et demi, onze (1927, 84’)
Sarebbe apparso molto migliore se si fosse evitato il pesantissimo, eccessivo e ingiustificato trucco dei fratelli (medici) protagonisti … solo per loro. Faccia bianca, contorno degli occhi e palpebre scurissime, labbra molto marcate, praticamente clown bianchi in questo ennesimo melodramma nel quale tutti gli altri appaiono “normali”.
La glace à trois faces (1927, 45’)
Mediometraggio quasi a episodi (punti di vista, ricordi e speranze di tre donne rispetto ad uno stesso (fatuo) ricco giovane. Ciò che dà valore al film, che per questo è apprezzato, è la tecnica; sceneggiatura debole, riduzione (forse eccessiva vista la durata del film) un romanzo di Paul Morand.
La chute de la maison Usher (1928, 63’)
Probabilmente il più famoso dei film di Epstein, basato sul famoso omonimo racconto di Edgar Allan Poe, adattato da Luis Buñuel che fu anche suo assistente regista come lo era già stato per Mauprat (1925). In questo terror classico si può facilmente ipotizzare la mano di Buñuel per alcuni dettagli non strettamente pertinenti alla trama. La seconda parte del film è un vero esercizio di montaggio e riprese. Parafrasando il titolo di un commento (che condivido): guardatelo sotto ogni aspetto tranne che per la trama e lo troverete ottimo.
In conclusione, questa incursione fra i 13 muti di Epstein evidenzia la sua continua ricerca tecnica ed espressiva, nei vari generi affrontati seppur tutti hanno in comune una parte melodrammatica. Grande importanza ai primissimi piani dei volti, ai dettagli e alla recitazione con le mani. Come punti deboli, vedo l’indugiare troppo a lungo su singole scene (anche quando è perfettamente chiaro il significato) e la scelta (ma solo nei primi film) di far muovere estremamente lentamente i protagonisti, quasi come automi, assolutamente in modo irreale e poco plausibile, inutilmente teatrale.
Etichette:
Age d'or,
Atalante,
avanguardia,
avant-garde,
Buñuel,
cinema,
Dalí,
Dulac,
Epstein,
film,
francese,
impressionismo,
muto,
Poe,
surrealismo,
Vigo
martedì 7 maggio 2019
37° gruppo di 5 micro-recensioni 2019 (181-185)
Dopo la cinquantina di film visti in neanche
20 giorni alla Cineteca Nacional Mexico
e durante i lunghi viaggi, torno a ritmi più normali con 3 muti (due dei quali
di Fritz Lang), un lavoro georgiano
quasi d’avanguardia e uno stranissimo film di Carlos Saura, che vede come personaggio principale un giovane Luis Buñuel, con i suoi amici dell’epoca Salvador
Dalì e Federico Garcia Lorca.
Interessante esercizio di stile, soprattutto per i cinefili e/o per gli
appassionati di horror che sono incuriositi anche dai film degli albori di tale
genere.
Le oltre 1.400 precedenti micro-recensioni dei film visti a partire dal 2016 sono sul mio sito www.giovis.com; le nuove continueranno ad essere pubblicate su questo blog.
181 Una
donna sulla luna (Fritz Lang, Ger, 1924) tit. it. “Frau im Mond” * con Klaus Pohl, Willy Fritsch, Gustav von Wangenheim *
IMDb 7,4 RT 71%
Ottimo film di Lang, a me precedentemente del tutto sconosciuto, ben
diverso dai suoi soliti drammi. Si sviluppa brillantemente fra i generi sci-fi,
crime, romantico, avventura, drammatico e perfino un po’ di commedia. Trama
avvincente, piena di sorprese, narrata con perfetta scelta di tempi e con una
grammatica filmica tanto chiara da rendere quasi inutili i cartelli, a
prescindere dalle buone prove degli interpreti. Le visioni futuristiche alla Verne risultano particolarmente interessanti
così come le soluzioni scenografiche per il viaggio spaziale, con fondali e
disegni che riprendono in parte quelli di Méliès.
Buona parte del film tratta degli avvenimenti che precedono la
spedizione, che parte in fretta e furia con un equipaggio eterogeneo, assortito
all’ultimo istante. Considerato che il titolo anticipa che il viaggio di andata
avrà successo, resta il dubbio (fino all’ultimo minuto) in merito a chi tornerà
sulla terra .... forse. I singolari personaggi sono tutti ben descritti, così
come la rapida sequenza di incidenti concernenti il manoscritto degli studi,
progetti e disegni del prof. Manfeldt.
La sceneggiatura è tratta da un romanzo di Thea von Harbou, moglie di Lang
dal 1922, e curata dalla stessa, che fu coautrice di quasi tutti i muti diretti
dal consorte e anche del successivo eccezionale M - Il mostro di Düsseldorf (1931), in precedenza era stata anche
seceneggiatrice di Phantom (1922,
Murnau).
Le 2h40’ passano velocemente e piacevolmente. In rete si trovano
versioni di buona qualità
185 La
chute de la maison Usher (Jean Epstein, Fra, 1928) tit. it. “La caduta
della casa Usher” * con Jean Debucourt, Marguerite Gance, Charles Lamy* IMDb 7,4 RT 100%
Un classico fra i muti francesi, chiaramente tratto dal famoso omonimo racconto
di Edgar Allan Poe, con la seconda
parte molto “sperimentale”. Non troppo fedele alla storia originale, il regista
Jean Epstein (nato in Polonia, all’epoca
Impero russo) propone pochissima azione scegliendo di concentrarsi sulla descrizione
dei tetri ambienti della magione e nella creazione di un’aria di mistero e di angoscia.
I cartelli sono pochissimi e accade molto poco, ma le sequenze di dettagli,
ombre sinistre, ralenti situati ad arte, particolari quasi macro, sono
certamente notevoli e creano l’atmosfera desiderata senza aver bisogno di
effetti speciali e musica da thriller-horror.
Chi legge i credits non può fare a meno di notare che l’adattamento del
racconto è di Luis Buñuel e che l’attrice
protagonista è Marguerite Gance, che
l’anno prima aveva interpretato Charlotte Corday in Napoléon (1927), diretto da suo marito Abel Gance , il quale compare nelle prime scene di questo La caduta della casa Usher nei panni di
uno degli avventori del bar.
182 Quattro
intorno a una donna (Fritz Lang, Ger, 1921) tit. it. “Vier um die Frau” *
con Hermann Böttcher, Carola Toelle, Lilli Lohrer * IMDb 6,4
Girato pochi
mesi prima di Destino (1921), è l’ultimo
film “minore” del periodo tedesco di Lang.
Sceneggiato
come tanti altri dal regista insieme con la moglie Thea von Harbou, soffre un po’ della sua origine teatrale e la precisa
direzione e l’ottima fotografia non sempre sono sufficienti a superare questa “staticità”.
Vier um die Frau fu stato
considerato perso per molti anni, fin quando, nel 1986, nei depositi della a Cinemateca
de Sâo Paulo (Brasile) ne fu ritrovata una copia locale con titolo Corações Em Luta (lett. Cuori
in lotta).
183 Mizerere (Zaza Khalvashi, Georgia, 1996)
tit. int. “Miserere” * con
Zura Sturua, Manana Davitashvili, Nino Kasradze
Secondo film del regista del sorprendente Namme (2017) del quale ho scritto qualche giorno fa. Venti
anni prima Zaza Khalvashi aveva
già buone idee ma fra budget limitato e idee ancora “confuse” Mizerere è ben distante dalla
sua opera più recente. Sembra che fosse ancora indeciso su che strada prendere,
a tratti sembra sperimentale in stile Godard,
in altri casi già lascia intuire la sua ammirazione per Tarkovski. Trama e dialoghi volutamente vaghi trattano di politica
e rivoluzione non collocabili in nessun luogo e periodo particolare. Il regista
affermò che voleva descrivere i "demoni che vivono dentro e tra noi" invitando
tutti a “vergognarsi delle atrocità contro sé stessi e contro altri”.
Interessante, ma ben distante dalla qualità del suo più recente lavoro.
184 Buñuel
y la mesa del rey Salomón (Carlos Saura, Spa, 2001) tit. it. “Buñuel e la
tavola di re Salomone” * con El Gran Wyoming, Pere Arquillué, Ernesto Alterio *
IMDb 5,7 RT 36%p
Un film di Saura con Buñuel
come personaggio principale, affiancato dai suoi amici di gioventù Salvador Dalì e Federico Garcia Lorca, non me lo potevo lasciar scappare, pur
sapendo che che gode di scarsa
reputazione. In effetti non sono ancora riuscito a capire perché Saura (notoriamente amico e grande
estimatore del regista aragonese) abbia avuto l’idea di co-sceneggiare e
dirigere questo film, fra il surreale, il fantasy e il dramma. Il soggetto
potrebbe anche essere considerato meritevole ma, per come è stato sviluppato in
sceneggiatura, è diventato una serie di citazioni verbali e visive (molte
addirittura troppo evidenti) di tanti film di Buñuel e alcuni di Saura
(ma anche di altri come Metropolis,
di Lang) e dei rapporti fra i 3 che
furono amici solo fino alla Guerra Civile spagnola degli anni ’30 (Buñuel dovette fuggire oltreoceano, Dalì rimase a sostenere il franchismo, Lorca fu fucilato per essere
omosessuale e socialista). Alcune ambientazioni e scene rimandano invece
direttamente a film di avventura, tipo Indiana Jones.
Come se non bastasse, il cast è mal assortito e di livello non proprio
eccellente, comprende addirittura 2 “grandi attori” italiani: Armando de
Raza e Valeria Marini!
Può divertirsi (molto relativamente, cogliendo la tante citazioni) solo
chi conosca l’intera filmografia di Buñuel
e sa un poco dei lavori degli altri due, nonché dei classici del cinema in
generale; a chi è poco ferrato in tali campi la maggior parte del film sembrerà
puro nonsense.
Le oltre 1.400 precedenti micro-recensioni dei film visti a partire dal 2016 sono sul mio sito www.giovis.com; le nuove continueranno ad essere pubblicate su questo blog.
Etichette:
Abel Gance,
Buñuel,
Cannes,
cinema,
classici,
Epstein,
film,
Fritz Lang,
Khalvashi,
noir,
oro,
Oscar,
Salvador Dalì,
Saura,
Valeria Marini,
Venezia,
world cinema
Iscriviti a:
Post (Atom)